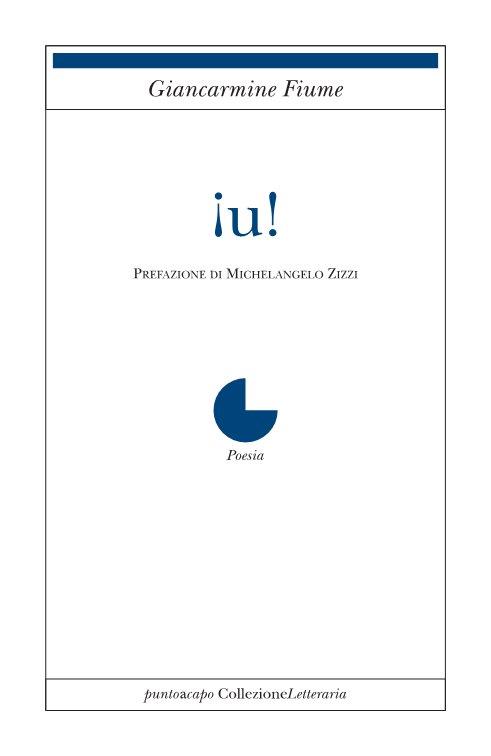Il titolo dell’opera in versi di Giancarmine Fiume (la “u” minuscola preceduta da un punto esclamativo scritto al contrario e seguita da un punto esclamativo scritto diritto-versione canonica-) è, a mio avviso, il tratto letterario centrale e concettualmente corretto, per intendere, nel suo complesso, il poemetto dell’autore; tratto necessario per evitare accostamenti ermeneutici e interpretazioni devianti del senso della silloge.
Di che si tratta quindi? Innanzitutto la “u” minuscola (ultima tra le vocali), come la “a” minuscola di J. Lacan (iniziale del piccolo “altro”, istituita dal famoso psicoanalista francese e oggetto dell’inconscio incontrollabile per l’io) è ciò che muove involontariamente il corpo, la psiche e, più precisamente, l’esserci stesso del poeta verso il basso (degli inferi) e verso l’alto (dell’empireo), secondo quanto indicano chiaramente i due punti esclamativi, se li si legge dal punto di vista squisitamente formale; anche se in apparenza in alcune poesie sembra che lo scrittore gestisca volontariamente determinate situazioni in cui viene a trovarsi.
G. Fiume inizia il suo viaggio verso il basso “In descensus inferis” ‘mentre scompare la luce popolare’, lasciando al mattino la posizione orizzontale terrena e concreta cioè il piano della quotidianità ordinaria che appare piuttosto desolante. Scrive, infatti, nella prima poesia della Silloge ‘alle otto e mezza antimeridiane c’è l’esilio sulla strada / di luminarie spente…sul retro delle case di edilizia convenzionata..ci sono panni stesi, cocci di bottiglie, sacchi / della raccolta differenziata’.
Il poeta avverte improvvisamente che ‘il lascito testamentario delle tue parole (parole della donna amata) trema sulle mie labbra’ e quindi si dirige verso il basso, verso il luogo dove può riconoscere la donna amata – ‘un vapore di terra, di femmina, tumultuoso / mi assale nell’iridescente rifrazione / riconosco il tuo sapore, nudo e maturo,/ di divinità in premenopausa, così, ad occhi stretti / sul retro di palpebre sigillate ora ti vedo / Sibilla Pavese’ -, che per il suo inconscio è l’oggetto necessario per assecondare il suo desiderio di amare, desiderio che non potrà mai essere soddisfatto perché connesso alla logica alienante dell’urgenza pulsionale e quindi verrà continuamente riproposto creando di fatto ferite nell’io del poeta (come si ravvisa in varie poesie di questa opera).
Urgenza pulsionale quindi (urgenza scritta con la “u” iniziale minuscola), urgenza d’amore certamente ma non Urgenza (con la U maiuscola) in senso ontologico, via certa verso l’Amore e il suo ruolo identitario, che comporrebbe la lacerazione dell’io del poeta ravvisabile nei significanti “amore” (necessità per esistere) e “dolore esistenziale” (punto di sbocco dell’amore) spazialmente e temporalmente uniti.
Certamente l’autore cerca alacremente di uscire dalla sua posizione iniziale, dal suo esserci di cui ha coscienza: scrive infatti all’inizio dell’opera ‘Guardami: io non esisto’; vuole quindi essere riconosciuto come esistente. Per avere tale riconoscimento nel suo viaggio tra inferi ed empireo usa molti registri linguistici tratti da diverse branche del sapere, registri che testimoniano ricerca di conoscenza. Scrive ‘nel fango rinserro i miei occhi e finalmente ti vedo, luce’ (ultima poesia della discesa agli inferi) in cui lo scrittore, da una posizione putrida, vede accendersi la speranza e nella prima poesia di ‘Chiara luce’ -seconda parte del poema- il poeta dice: ‘Sepolto dal bagliore/ sarà di ghisa l’estrema unzione (sepolto dalla luce avrà la dura estrema unzione, atto di morte e rinascita). Egli cerca continuamente e spasmodicamente il compimento erotico-amoroso ma il riferimento d’amore, “la Sibilla Pavese”-figura femminile a tratti fantasma evanescente a volte donna carnale, personificazione dell’oggetto materno primordiale (oggetto per sempre perduto e che ricerca senza mai trovarlo pur penetrando la donna nelle sue faglie)- di fatto lo trascina, lo fa muovere, lo illude nel suo immaginario ed in sintesi lo domina secondo un destino ineluttabile.
L’autore, con i suoi procedimenti linguistici, riesce senza dubbio a dare unità letteraria alla sua opera, la sua pelle significante, il suo esserci rimangono però in realtà lacerati.
Lo svuotamento dell’immaginario e l’emersione del reale attraverso significanti-parole (in senso lacaniano) che hanno funzione liberatoria e acquietante, secondo me, non avvengono nel poema di G. Fiume come invece accade, ad esempio, a V. Woolf nell’opera “Gita al faro” ed a J. Joyce nel romanzo “Finnegans Wake”.
Occorreva forse uno strappo, una violenta uscita dall’amore-malattia per la Sibilla Pavese, un
distacco da questa Donna assoluta che gli fa sembrare l’amore come una malattia che pur pensa guarisca omeopaticamente; occorreva una visione letteraria della donna (con la d minuscola) che dialetticamente, attraverso un percorso di svuotamento emotivo e linguistico conducesse il poeta a trovare un suo centro, una sua identità.
La “Sibilla Pavese” destina l’autore ad un dramma dal quale può riparare soltanto parzialmente attraverso il sogno-desiderio indicato nell’ ultima poesia; aspirazione verso un innalzamento ideale platonico: ‘Seguimi, oltre le palpebre così, spoglia di gravità’. Riparare parzialmente perché, in fondo, affinché non gli infligga dolore, la Donna amata deve perdere la sua concretezza (‘spoglia di gravità’), diventare ideale e sogno (‘oltre le palpebre’) ed i sogni sono certamente destinati a finire.
L’opera letteraria di G. Fiume è comunque convincente, se si evita di pensare la Silloge come percorso di un uomo verso l’equilibrio esistenziale. Il valore della stessa va cercato piuttosto nelle convincenti increspature linguistiche che creano ferite, nel sapiente uso delle parole e dal-
l’efficacia dei versi, nei mirabili componimenti che ineluttabilmente distanziano da qualsiasi dialettica della quiete, in alcune bene descritte caratteristiche della società odierna, società che conduce frequentemente all’alienazione e di cui la “Sibilla Pavese” è una espressione.
Mara David